

| prefazione | capitolo1 | capitolo3 | torna a Pigrecoemme.com |
CAPITOLO SECONDO
L'apologia del feticcio, ovvero: i frutti puri impazziscono
Chi si occupa delle
scienze umane ha bisogno di sapere altrettanto dell'occhio che vede quanto dell'oggetto
veduto.
CLYDE KLUCKHON
La mia visione di
che cos'è la realtà è molto soggettiva. Quando si fa un
film, la realtà è prima di tutto una convenzione: che cosa si
accetta di considerare come "reale" in un film? Si gioca su questo
al cinema.
DAVID CRONENBERG
All'interno dell'inesorabile progressione narrativa che innerva e sostanzia
l'agile intelaiatura fabulatoria di The Fly, è possibile isolare un preciso
momento (o per meglio dire una serie di momenti tra loro affini) in cui sembra
che le modulate cadenze dell'intreccio si condensino estaticamente in istanti
privilegiati, quasi a consentire il lento dispiegarsi di essenziali digressioni
significanti nonché, forse, per privilegiare la cristallizzazione filmica
di uno specifico topos di racconto, per enfatizzare la messa in scena di un
piccolo film nel film: ci si riferisce alle celeberrime sequenze di teletrasporto
in cui l'introverso scienziato Seth Brundle (efficacemente interpretato da JEFF
GOLDBLUM), prima utilizzando come cavia una scimmia poi, scoperta la praticabilità
e l'efficacia dell'esperimento sull'animale, addirittura scomodando se stesso,
tenta di concretizzare la trionfalistica validità delle sue mirabolanti
teorie sullo spostamento molecolare a distanza.
La serrata costruzione del découpage e la stringente logica filmica che
impregna e caratterizza le suddette sequenze, l'atmosfera sottilmente alienante
e claustrofobica che pervade il set del covo-laboratorio di Brundle, la febbricitante
esaltazione che attanaglia il novello Prometeo, il sortilegio ammaliante della
hybris al lavoro, tutto ciò concorre a determinare una particolare sospensione
ritualistica, una trepidante aspettativa del momento cruciale.
Se le suddette soluzioni estetiche sono innegabilmente assimilabili alle pratiche
rappresentative del modello originario, nonostante la maggiore potenza evocativa
e l'indubbia superiorità stilistica dimostrate dal remake, è altresì
fuor di dubbio che, in questa sequenza particolare, l'attenzione dello spettatore
rimane soggiogata da ben altri "prodigi" visivi: lo sguardo è
costretto ad una traslata e deviante osservazione dei materiali scenici (la
ritualità circolare della messa in scena ipostatizzata nel laboratorio
di Brundle, luogo coatto, concetrazionario, proscenio concettuale; quell'antropomorfico
dispositivo di teletrasporto, le cui capsule richiamano sfacciatamente cavità
uterine, è un arredo scenico un po' pruriginoso e anche un po' naïf,
un apparato plastico-figurativo che funziona come correlativo oggettivo del
sistema generativo dell'immaginario filmico) così consentendo un'accentuazione
metaforica del materiale narrativo di base.
Il vero senso dell'operazione è da intendersi cioè in una più
complessa chiave metalinguistica, tant'è che l'artificiosità romanzesca
del récit non offusca né la scoperta propensione epistemologica
del film sulla reale natura del cinema né la sua acuta riflessione sul
meccanismo riproduttivo delle immagini; tutte caratteristiche ineludibili, tutte
costanti irrinunciabili del regista canadese, la cui vera firma autoriale si
estrinseca pienamente proprio nella reiterata esplorazione di tali nessi tematici.
Seguendo l'esempio illuminante di Videodrome, CRONENBERG organizza il materiale
visivo di The Fly in modo tale da consentire e legittimare una contrattazione
polivalente dei suoi numerosi riflessi significanti: alla primaria composizione
figurativa è sottesa una serie di stratificazioni semantiche, una rete
di segni e rimandi plurimi che è compito precipuo dello spettatore decodificare.
In questo senso tutto il processo del teletrasporto, al dì là
della sua evidente funzione narratologica e del suo innegabile fascino spettacolare,
è osservabile come brillante trasposizione visiva di un altro tipo di
spostamento, l'analogia figurale di un tendere empatico del soggetto nei confronti
del suo oggetto di riferimento; si tratta, in buona sostanza, della visualizzazione
"corporea" e materiale di un trasferimento del tutto astratto e mentale,
"quello del cineasta verso il suo film, dell'attore verso il suo personaggio,
del corpo filmato e registrato da una telecamera, punto per punto, atomo per
atomo, e ricomposto altrove sotto la forma di un'immagine di questo corpo. Da
questo punto di vista, The Fly è la prima fiction moderna che metta in
scena la natura e il meccanismo dell'immagine[...].
Il problema, quando il corpo viaggia da A a B, è che la realtà
del corpo (la sua materia) diventa nel frattempo un'impressione di realtà:
solo un'immagine e più di un'immagine (la combinazione del significante
e del referente). CRONENBERG riflette appunto su questo meccanismo: che cosa
succede passando - attraverso l'immagine - dalla realtà alla sua "impressione"?
C'è un guadagno o una perdita di realtà?".
Nitido esempio della progettualità metalinguistica del regista, la sequenza
sottolinea, con icastica evidenza, l'insopprimibile penchant cronenberghiano
per un cinema che si rivela in tutta la sua pienezza dinamica quando più
liberamente riesce a sperimentare forme riflessive su se stesso, quando sprofonda
la coscienza dello spettatore nella fremente e sensuale materia delle sue visioni,
quando spezza l'autorità monologica della rappresentazione facendo partecipare
tutti i decentrati attanti del composito scenario comunicativo, quando dispiega
vigorosamente il suo immaginario dissonante, proteiforme e multiprospettico
facendolo cozzare fragorosamente contro le omologanti e monolitiche forme delle
attuali "dittature" culturali.
* * *
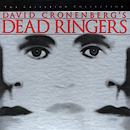
Le riflessioni sul cinema
in quanto dispositivo dotato di una precipua, ontologica autonomia linguistica
e le teorizzazioni sull'immagine come plurivoco organismo significante hanno
generato una letteratura talmente disordinata e ipertrofica da rendere ardua,
quando non addirittura proibitiva, ogni tipo di sistemazione teorica, qualsivoglia
ordinamento disciplinare, tant'è che anche le più meditate e rigorose
concettualizzazioni in materia finiscono sovente per confondersi e mescolarsi
col pedante esercizio accademico, col più vieto calembour teorico, con
le assonanze semantiche le più improbabili.
Scavalcando il caotico deposito della postmodernità e le lusinghe evanescenti
dell'ermeneutica pastiche, si è fatto ricorso alla duttilità olistica
dell'approccio antropologico. Un'antropologia visuale che, facendo leva sulle
più recenti teorie della comunicazione e su una focalizzazione sistematica
dei fondamenti epistemologici della rappresentazione per immagini, consente
un'esegesi innovativa ma oltremodo calzante delle problematiche messe in campo
da CRONENBERG. Tali problematiche, nate in virtù delle mirabili capacità
pervasive dimostrate dai linguaggi visuali, bene riflettono il vacillante assetto
di una società caratterizzata da paradigmi culturali sottomessi al potere
feticistico del regime eidetico e palesemente compromessi con la compatta virtualità
fenomenologica della nuova fantasmagoria massmediale.
Risulterà chiaro come la ricchezza ermeneutica e la vastità concettuale
dell'oggetto di ricerca finiscano in realtà coll'interessare molteplici
ambiti teorici e svariati settori disciplinari. Se si è scelto un particolare
tipo di metodo, che, lo ripetiamo, richiama le più recenti acquisizioni
dell'antropologia visuale, è perché ci sembra indispensabile dare
particolare risalto alle significative conseguenze antropologiche che l'intrinseca
virulenza del linguaggio delle immagini ha determinato. La limitazione del campo
di ricerca, che avrà, se non altro, il pregio della compattezza e dell'omogeneità,
rispetto ad una materia generalmente frastornante per la quantità dei
contributi e dispersiva per la qualità delle proposte, contribuirà
a scansare le trappole formalistiche e gli astratti teoremi dell'interpretazione
semiotica, così come le sistematizzazioni globalizzanti e le forzature
deterministiche dell'approccio sociologico.
È per questo che il viaggio all'interno dell'opera di CRONENBERG sarà
organizzato e costruito attorno ai tre grandi nodi tematici su cui verte la
più audace e spregiudicata ricerca antropologica applicata ai linguaggi
visuali: a) la messa in discussione e la definitiva crisi della rappresentazione
monologica, con il conseguente superamento delle pretese oggettivanti delle
immagini in movimento, a favore di un manifesto esercizio metalinguistico dei
codici iconici (il tutto reso possibile dopo l'esperienza antropologica di MARGARETH
MEAD e RHODA MÈTRAUX); b) la frantumazione e la dispersione dello sguardo,
la pratica dell'accostamento e dell'ibridazione, il ribaltamento scopico, la
visione frammentata e a collage nei nuovi modelli di rappresentazione visuale
proposti da CLIFFORD, MARCUS & FISCHER; c) la nascita di un nuovo scenario
epistemologico (preconizzato con ammirevole lucidità da WALTER BENJAMIN)
e la coniugazione di nuovi modelli teorici (CANEVACCI, APPADURAI) che funzionano
da indicatori culturali di un panorama visivo e mediale visto come superba fantasmagoria
feticistica, come denso e isomorfo tessuto inter-connettivo e comunicazionale,
come anamorfico dispositivo ontologico.
***
 Al
di là delle spettacolari e raccapriccianti mutazioni a cui il cinema
di CRONENBERG non sembra poter mai rinunciare, al di là delle provocazioni
visive e tematiche che hanno spesso ostacolato la fortuna pubblica dei suoi
film (scandalizzando i benpensanti e le autorità di mezzo mondo, inorridendo
i composti e paludati cultori delle informi politezze espressive, esasperando
i miseri fautori di un'arte sovranamente concettosa e levigata), il cinema del
canadese trova la sua dimensione più significativa proponendosi come
implacabile macchina riflessiva sull'instabilità epistemologica dell'immagine
e i difformi codici segnici che la caratterizzano, sulla debordante pervasività
dell'immaginario visivo ed i sottili nonché sfuggenti meccanismi attraverso
cui tale immaginario si palesa allo spettatore.
Al
di là delle spettacolari e raccapriccianti mutazioni a cui il cinema
di CRONENBERG non sembra poter mai rinunciare, al di là delle provocazioni
visive e tematiche che hanno spesso ostacolato la fortuna pubblica dei suoi
film (scandalizzando i benpensanti e le autorità di mezzo mondo, inorridendo
i composti e paludati cultori delle informi politezze espressive, esasperando
i miseri fautori di un'arte sovranamente concettosa e levigata), il cinema del
canadese trova la sua dimensione più significativa proponendosi come
implacabile macchina riflessiva sull'instabilità epistemologica dell'immagine
e i difformi codici segnici che la caratterizzano, sulla debordante pervasività
dell'immaginario visivo ed i sottili nonché sfuggenti meccanismi attraverso
cui tale immaginario si palesa allo spettatore.
Lavorando all'interno della peculiare convenzionalità strutturale che
sottende l'immagine in movimento, facendosi carico della connaturata ambiguità
linguistica che impregna il linguaggio visuale, CRONENBERG modella tutto il
suo corpus cinematografico come una metacritica della comunicazione visuale,
che richiama, e spesso risolve, gli assillanti interrogativi teorici sollevati
dagli attuali studi sulla cultura dell'immateriale.
Sviluppando l'interesse dimostrato fin da ragazzo per le eziologie virologiche
(interesse coltivato accademicamente durante i primi anni di studio nel dipartimento
di biologia e ben presto abbandonato a favore delle materie umanistiche e dell'incerta
pratica amatoriale del cinema), CRONENBERG adatta il suo occhio di cineasta
horror alle procedure metodologiche della scienza; è così che
riesce a guardare ai meccanismi della riproduzione visiva come fertili ricettacoli
di forze parassitanti, e a stabilire la natura delle immagini in base non più
al loro coefficiente di verità, bensì al loro livello di "infezione".
Viste tali premesse, non è certamente difficile inserire il cinema cronenberghiano
nel solco di una tradizione letteraria che fa capo agli innovativi exploit multistilistici
di un WILLIAM FAULKNER o di un HERMAN MELVILLE, non dimenticando l'illustre
precedente di JOSEPH CONRAD e del suo seminale Heart of Darkness (Cuore di tenebra,
1902): racconti modulati sulla frastornante polifonia dei punti di vista, costruiti
sulla frantumazione del centro narratologico, caratterizzati dallo sgretolamento
dell'autorità del narrante.
Ma alle soluzioni linguistiche e di racconto che interessano uno spazio specificatamente
testuale, si va ad aggiungere, nel caso di CRONENBERG, una querelle di stampo
prettamente e squisitamente cinematografico: "per lo spettatore, infatti
[la macchina da presa] è quasi sempre uno spettatore onnisciente, una
fonte di informazione attendibile, che non "mente" mai. In quanto
spettatori prestiamo fede alle immagini, come se fossero i nostri sensi".
Ed è in questa precisa ottica che vanno ascritte le singolari soluzioni
sintattiche sperimentate in film come Videodrome, The Dead Zone, Naked Lunch
ed eXistenZ, veri e propri teoremi filmici, fatti per sabotare l'indolente coscienza
di uno spettatore sempre più assuefatto e passivo, inevitabilmente prigioniero
di vieti e logori cliché interpretativi.
È fuor di dubbio che CRONENBERG si muove in uno spazio creativo umbratile;
non è difficile figurarselo mentre fa lavorare la sua immaginazione in
quella sottile zona morta, in quel lembo interstiziale che si frappone fra le
convenzioni strutturali del racconto e le attese dello spettatore, per sovvertire
le prime dall'interno trasformando di riflesso le seconde in una serie di frustranti
depistaggi. Un gioco di padronanza metodologica in cui sono maestri i grandi
narratori dei romanzi gialli o dei racconti a suspense, affabili propiziatori
della detection semiotica; ed è, quello del paradigma indiziario, un
buon punto di partenza operativo per la decodifica di una cinematografia sfaccettata
e complessa che ha bisogno, per essere pienamente fruita, di uno scavo nel particolare
e nel dettaglio per risalire alla totalità della concezione.
CRONENBERG declina quest'escroquerie linguistica per assicuraci, attraverso
i singulti e le peristalsi della nostra straniata percezione (coitus interruptus
della rassicurante coazione a ripetere), la necessaria strumentazione "fisiologica"
per decriptare il flusso invasivo e magmatico della visione e così scomporla
nei suoi elementi essenziali; per carpirne le leggi segrete, per padroneggiarne
la grammatica, per spezzarne l'incantesimo.
I suoi film sono consapevoli operazioni di svelamento delle aporie gnoseologiche
in cui vanno inevitabilmente ad inciampare tutti i meccanismi di riproduzione
del reale, il suo cinema è lucidissimo memento mori sull'inequivocabile
convenzionalità di ogni linguaggio, in special modo quello cinematografico,
tarato irresistibilmente dal paradosso, vecchio tanto quanto PLATONE, di un
presunto regime oggettivo-mimetico restituito dalle immagini in movimento. Lo
scavalcamento dello sguardo speculare ed uniforme a favore di una coscienza
di visone prismatica e concettuale è condotto sia all'interno della funzionalità
espressiva del film, sia mettendo in relazione dialettica l'eterodossa retorica
del film stesso con una ben localizzata ed indagata tradizione espressiva.
Del primo caso sono esempi calzanti Videodrome, Naked Lunch ed eXistenZ, non
solo perché mettono in scena vicende e personaggi in bilico fra vari
ordini di realtà (in Videodrome Max Renn, alla ricerca disperata di un'immagine
realisticamente pornografica, propugnatore ad oltranza dello snuff movie, scivola
impercettibilmente nell'allucinazione più efficace, nella più
convincente delle virtualità; ma anche il racconto del bohemien Bill
Lee, mentre scrive e vive il suo Naked Lunch, procede con la stessa fluidità
onirica di un trip allucinatorio, vivendo di sdoppiamenti e mutazioni incessanti,
perdendosi nell'ebbrezza fumigante dell'immaginazione, confondendo sogno e vita
reale, arte e vissuto, immaginazione e autobiografia; così come, d'altra
parte, i creatori di un videogame di successo, che si chiama, guarda caso, eXistenZ,
si ritrovano intrappolati in uno scenario di pregnante materialità e
di mortale realismo) bensì perché miscelano senza soluzione di
continuità immagini mimetico-realistiche ad immagini onirico-allucinatorie
(così impedendo qualsivoglia demarcazione dell'origine del narrato e
frustrando il bisogno spettatoriale di aggrapparsi ad una figura di rassicurante
autorità enunciativa). È lo stesso spettatore a provare, nel momento
della contrattazione dei significati, un'insormontabile difficoltà ermeneutica
nei confronti di un'immagine che si trova a dover essere codificata sulla base
di coordinate di cui non siamo a conoscenza.
Il secondo caso è molto ben illustrato da questo passo tratto dall'eccellente
libro di SERGE GRÜNBERG: "Ne La zona morta, Johnny Smith [interpretato
da CHRISTOPHER WALKEN], in seguito a un incidente stradale, cade in un lungo
coma al termine del quale scopre di essere in grado, solo toccandole, di vedere
il futuro delle persone, o piuttosto le potenzialità delle loro esistenze.
Messo di fronte a Greg Stillson (MARTIN SHEEN), un candidato demagogo a un'elezione
locale, scoprirà, stringendogli la mano, che questi potrebbe diventare
un presidente fascista pronto a scatenare una guerra nucleare. Lo stesso CRONENBERG
ha insisto più volte sulla condizione paradossale in cui si trova lo
spettatore dei suoi film: in effetti noi consideriamo queste visioni come vere.
Coinvolti dalla narrazione e dall'aspetto patetico del personaggio "ritornato
dal mondo dei morti", non dubitiamo mai della verità delle sue visioni[...].

In tal modo, parlando di uno dei pochi film di cui non ha scritto interamente
la sceneggiatura, lineare e hollywoodiana, con un finale "morale"
e relativamente "positivo", è lo stesso CRONENBERG a metterci
di fronte al paradosso del suo sistema. Si auspica la morte del demagogo, persuasi
solo dal fatto che ci è stato mostrato (una sorta di sindrome da disinformazione)
come un HITLER in potenza. Certo, il versante "naturista" del film
ci dice che quel mediocre individuo è un demagogo. Ma che cosa sappiamo
delle visioni di Johnny? Che cosa ci fa pensare che siano vere? Solo il fatto
che crediamo alle immagini e che siamo, da molto tempo, contaminati dal "virus"
hollywoodiano (la lotta del Bene contro il Male che legittima e giustifica le
peggiori reazioni), da una pseudomorale da talk-show televisivo che ci affida
effettivamente una missione spaventosa quanto risibile: abbassare il pollice
come faceva la plebe romana al circo, decidere della vita e della morte di personaggi
il più delle volte immaginari[...].
Il professor O'Blivion [in Videodrome] non ha quindi torto, "la sola realtà
è quella che percepiamo con i nostri sensi" e l'immagine, fra tutte
le forme di traduzione del visibile del mondo reale, è quella più
facilmente contaminabile, la meno degna di fede. La dichiarazione di CRONENBERG
esprime dunque una posizione e una prassi che fanno pensare, da un punto di
vista morale, al cinema di GODARD".
Pensato in virtù della sua edonistica e appagante capacità autoriflessiva,
subìto come veicolo propagandistico dei feticci della cultura egemone,
il cinema ha ormai irrimediabilmente perso la sua pristina "verginità"
enunciativa, la sua purezza di rappresentazione, la sua oggettività di
sguardo, il suo nitore poietico, la sua capacità di "presa"
immediata sul reale. Grava sull'immagine filmica un tale affastellamento segnico,
un così pesante fardello codicale, un siffatto inquinamento iconico da
assecondare la proliferazione di una nuova genia di autori cinematografici,
una folta schiera di docili emuli e pedissequi imitatori che, inchinandosi ad
una temperie culturale giustificata e persino nobilitata dal vano prolungarsi
delle estetiche postmoderne, si trincerano nel culto della copia e della serializzazione,
indulgono all'ammiccamento referenziale, si appagano solo dell'usura citazionista.
![]()
A meno che non siano autori come GODARD o CRONENBERG a spezzarne il sortilegio
ferale, ad abbatterne la mefitica pervasività e a restituirci tutta la
sfuggente carica esplosiva e la potenziale radicalità eversiva di un
linguaggio ancora tutto da scoprire, al tempo stesso formidabile medium diagnostico-interpretativo
del sistema culturale e mirabile strumento filosofico di ripensamento delle
categorie speculative. Al di là di una certa rassomiglianza, come ci
suggerisce l'intervento di GRÜNBERG (rassomiglianza che diventa innegabile
se si accostano alcune soluzioni concettuali presenti tanto in Numéro
deux, t.l.: Numero due, 1975 quanto in Videodrome ), il francese e il canadese
divergono, oltreché per il fatto di essere figli di logiche economico-culturali
affatto diverse, anche per le antitetiche metodologie con cui costruiscono,
o meglio de-costruiscono, il rapporto fra opera e spettatore: una distanziazione
dialettica nei confronti delle vicende raccontate, uno sconvolgimento delle
dinamiche drammaturgiche attraverso un montaggio vistosamente anacolutico, un
trattamento scopertamente saggistico del materiale filmico finisce per produrre
un estraniamento quasi brechtiano in GODARD; d'altra parte in CRONENBERG una
partecipazione al tempo stesso sofferta ed estatica, seppure critica ed oggettiva,
nei riguardi delle tematiche affrontate, un montaggio "invisibile"
e apparentemente classico, una fabula che s'inchina agli archetipi della narrativa
di genere costringono lo spettatore ad un'esperienza antifrastica, tanto più
analitica e distaccata quanto più vissuta all'interno delle rassicuranti
leggi della spettacolarità.
Se divergenti, quasi antitetiche, risultano le soluzioni espressive, medesimo
è però l'intento finale: la riflessione disincantata e progettuale
sui poteri "occulti" dell'immagine e la sua permeabilità segnica,
e, complementare a questa, la ricerca di idealità visuali che siano sfaccettate,
plurali, decentrate, anti-convezionali, la speranza di un'autonomia gnoseologica
dei linguaggi da essa veicolati, per non dire di una fiducia ingenuamente cinefila
nelle nuove strumentazioni espressive.
* * *
Che l'immagine fotografica fosse
molto di più (o molto di meno) di uno strumento riproduttivo del reale
lo aveva capito, in tempi non sospetti e con una preveggenza quasi miracolosa,
CHARLES DARWIN. Questi, per convalidare la sua ipotesi secondo la quale alcune
modalità dell'espressione umana rivelano un particolare aspetto del continuum
evolutivo che lega animali e uomini, si servì della fotografia quale
strumento di indubitabile rispondenza empirica.
Ma al contrario dei suoi contemporanei, si pensi per esempio alle analoghe ricerche
di DUCHENNE, DARWIN raccolse i suoi dati seguendo un approccio metodologico
a dir poco rivoluzionario; è grazie a questo particolare tipo di approccio
che si poterono per la prima volta affrontare problematiche teorico-epistemologiche
di estremo interesse nonché di impressionante attualità: "...a
differenza di DUCHENNE, che era tanto entusiasta del nuovo mezzo da ritenerlo
"perfetto", egli era affatto consapevole dei suoi limiti e, di conseguenza,
pose come centrale la questione dell'osservazione, della registrazione e della
analisi dei dati mediante la fotografia. In altri termini l'immagine fotografica
non costituisce in sé un dato ma semplicemente un modo di raccogliere
dati e di analizzarli[...]. Una fotografia non può parlare da sé;
al contrario la registrazione fotografica deve essere integrata in un processo
di osservazione e di verifica dell'ipotesi in relazione all'osservazione...
anche una fotografia non "naturale" ma "costruita" poteva
quindi essere utilizzata per confermare le ipotesi [di partenza]".
Ci si perdoni l'audacia dell'accostamento, la repentinità di questo brusco
balzo temporale che può apparire francamente stordente, la singolarità
della sovrapposizione di due linguaggi (la fotografia scientifico-documentaria
e la fiction cinematografica più consapevole) apparentemente distanti
anni luce. C'è però un filo sottile che lega queste esperienze,
un trait d'union illuminante che bene illustra le problematiche sollevate dal
cinema cronenberghiano. Problematiche che riguardano le possibilità linguistiche
della settima arte, gli utilizzi retorico-descrittivi che l'hanno interessata
e, più significativamente, l'ancora latente autonomia strutturale delle
immagini, troppo spesso sacrificata ed assimilata agli altri mezzi di espressione.
Si è perciò tentato di accostare taluni pressanti interrogativi
teorici inerenti all'antropologia visuale alle riflessioni metalinguistiche
generate dall'opera del regista, cercando, con ciò, di sottolineare il
carattere di lucida consapevolezza autoriflessiva e la profonda tensione speculativa
che interessa gran parte della filmografia di CRONENBERG.
Cominciando col tema principe e ineludibile della sua ricerca cinematografica,
quello della convenzionale qualità mimetico-oggettiva dell'immagine e
della sua presunta capacità di riproduzione empirica, argomento che percorre
come un fil rouge l'intera storia della disciplina. Strettamente connesso con
questo, il consequenziale e non meno fondamentale problema della costrizione
monologica della rappresentazione visiva, costrizione diventata per così
dire endemica in virtù del particolare "trattamento" culturale
a cui è stato sottoposto il mezzo; infine, l'ansia policentrica e metalinguistica
tesa ad un difficile superamento dell'autorità auto-riproduttrice del
visuale, attraverso cui si giustificano le sue stagnanti e omologanti retoriche.
La volontà di non fermarsi all'apparenza levigata della materia ma di
penetrarne le viscere, l'ambizione d'incunearsi nel cuore pulsante dei fenomeni
per osservarli in tutta la loro dinamica estensione, lo sforzo di dilatare l'immagine
oltre i suoi patenti limiti riproduttivi rappresenta per CRONENBERG un imperativo
estetico, quando non addirittura morale: c'è sempre un sottotesto, un
sostrato significante e profondo in ognuna delle sue immagini (Videodrome, The
Dead Zone, The Fly, Dead Ringers), c'è un immersione dello sguardo in
territori e spazi normalmente preclusi all'occhio umano (The Brood, Scanners,
Naked Lunch), c'è una instancabile ricerca di illuminazioni prismatiche
e polisemantiche (Videodrome, Crash, eXistenZ); una poetica della visione riassumibile
nel suo motto programmatico: "Voglio mostrare quello non si può
mostrare, dire ciò che non si può dire".
Quella stessa volontà, restando ferme le differenziazioni metodologiche
e disciplinari, l'hanno espressa anche alcuni filmmaker d'impostazione antropologica
che, per raggiungere un presupposto livello di realtà documentaria, non
si preoccuparono di alterare scenicamente il profilmico per esigenze espressive
oppure di mettere in scena (secondo un grado del reale fotografico definito
come staged authenticity) accadimenti ed eventi etnologici con la collaborazione
partecipante dell'oggetto ripreso; così come non rinunciarono, grazie
ad una straordinaria e decisiva intuizione, alla possibilità di una vera
e propria compartecipazione creativa, facendo intervenire la persona ripresa
nella realizzazione tecnico-artistica del materiale filmico, sia in sede di
riprese sia in sede di montaggio, e trasformando di conseguenza l'oggetto osservato
in soggetto che osserva.
Concepito, e parimenti accolto, come accurato strumento riproduttivo del reale,
il cinema è da sempre vissuto, in realtà, su un evidente, quanto
paradossale principio: quello secondo cui la configurazione ideazionale dei
segni grafici, che compongono fisicamente un'immagine, debba essere apoditticamente
decifrata come oggettivo simulacro del reale. Si tratta, va da sé, di
un evidente equivoco su cui ha tentato di fare particolare chiarezza proprio
l'antropologia visuale, disciplina costituzionalmente votata allo studio dell'altro.
L'enfasi posta sulla interdipendenza connotativa fra l'utilizzazione linguistica
del visuale, o di ogni altro linguaggio, e le categorie culturali del pensiero,
testimonia, sia da parte delle più recenti dottrine antropologiche, sia
da parte di un regista horror di successo come CRONENBERG, d'un urgente bisogno
di riflessione teorica sulla centralità storico-culturale dei processi
comunicativi.
Mirabilmente celata da un'immaginazione grottescamente bizzarra, da una perversa
cauchemarderie di sguardo e dall'efficacia drammatica di uno spettacolo abilmente
cadenzato, l'opera di CRONENBERG nasconde in realtà una non troppo velata
anamnesi delle sintomatologie pervasive dimostrate dai linguaggi visivi, incoraggiando
un approccio interpretativo che tenga conto delle enormi risorse simboliche
e delle molteplici rispondenze semiotiche che allignano in ogni testo visuale.
Sia quando è principale materia di racconto (come in Videodrome, Naked
Lunch o eXistenZ) sia quando è dispersa nei flussi narrativi di vicende
apparentemente distanti (Scanners, The Dead Zone, Crash), CRONENBERG mette in
scena, con radicalità espressiva e consapevolezza teoretica, la metamorfosi
del gravido corpo comunicazionale, capace di secernere un immaginario gestaltico
che va feticisticamente e anamorficamente interpretato.
Se si deve a ROLAND BARTHES (si veda in proposito il suo cruciale intervento
per sviscerare i nessi che legano le esigenze della scienza con le metodologie
"aperte" dell'arte) di avere intuito l'importanza di un discorso sanamente
metatestuale sulla comunicazione, e di avere così indirizzato l'antropologia
visuale verso la convinzione che "il testo visuale tende a rilevare informazioni
sull'evento o la persona rappresentati e insieme su colui che ha prodotto quel
testo, sul suo modo di vedere, interpretare e rappresentare la realtà",
sottolineando "un punto particolarmente importante nel quadro dell'antropologia
contemporanea, che si pone sempre più esplicitamente come osservazione
"circolare" (noi-loro-noi) e non più verticale ed unidirezionale
(noi-loro)", è certo che gran parte del merito per aver suggerito,
in verità con una certa dose approssimazione, un tale tipo d'approccio
va senz'altro ascritto a MARGARETH MEAD e RHODA MÉTRAUX, propugnatrici
di una osservazione antropologico-sociale condotta a distanza.
Intuendo la possibile "verità" culturale di un documento filmico
e costrette dalle circostanze a caldeggiare un'osservazione ermeneutica condotta
considerando il fenomeno comunicativo nella sua logica globale, le due studiose
si sono proposte come curatrici di una pregevole, quanto innovativa, antologia
critica. Nata dall'impossibilità di reperire materiali antropologici
sul campo, a causa degli avvenimenti bellici degli anni Quaranta, e perciò
considerata anomala e metodologicamente eterodossa, questa silloge di interventi
critici rivela straordinarie intuizioni di metodo ed un'insospettabile apertura
ideologica.
Se anche permangono letture parziali, inficiate da considerazioni poco più
che folcloristiche e caratterizzate da applicazioni sociologiche nei confronti
di film che dimostrano una palese artificiosità di costruzione (cfr.
l'analisi di Caccia tragica, 1946 di DE SANTIS, mancato tentativo di utilizzare
variabili di psicologia dinamica nella descrizione di un'opera evidentemente
girata, come nelle vene del regista, assecondando gli stereotipi plastico-figurativi
e ritmico-sintattici del cinema hollywoodiano ed innestandoli in una cornice
neorealistica, quasi strapaesana), è indubbio che alcuni interventi colgono
in pieno, anche se per suggestione concettuale e non per precisione teorica,
quella dimensione intertestuale e quella prospettiva globale di cui si diceva
sopra.
Tanto MARGARETH MEAD quanto GREGORY BATESON scelgono, come oggetto della loro
indagine, due celebri esempi di cinema propagandistico: si tratta rispettivamente
di Molodaja Gvardija (La giovane guardia, 1948) di SERGEJ GERASIMOV e di Hitlerjunge
Quex (t.l.: Quex il giovane hitleriano, 1933) di HANS STEINHOFF. Una scelta
tutt'altro che neutra e casuale, poiché dimostra infallibilmente quanto
il cinema possa diventare e generare cultura soprattutto grazie alle sue specifiche
logiche interne. Cinema che, ben lungi dall'essere comoda ancora di salvezza
per una qualsivoglia tesi precostituita, viene così legittimato come
straordinario veicolo ideologico, risorsa linguistica capace di evocare e poi
plasmare modelli di pensiero e paradigmi culturali. Tant'è che se ne
mette debitamente in risalto sia l'autonomia gnoseologica che l'efficacia di
linguaggio, proprio per marcare la centralità imprescindibile delle sue
rispondenze fenomenologiche nel caleidoscopico scenario della civiltà
massmediale.
* * *
In uno scenario epistemologicamente
così problematico e dissonante è ovvio che le usuali categorie
interpretative tendano inevitabilmente a collassare, accelerando inevitabilmente
la crisi della rappresentazione. Un fenomeno di portata così vasta finisce
per interessare ovviamente svariati ambiti disciplinari: dalle scienze umane
alle letterature comparate, dall'architettura decostruzionista alla musica etnica.
Dopo l'esperienza del flâneur urbano di BAUDELAIRE, dopo il sistematico
sgretolamento dei sensi di RIMBAUD, dopo la scomposizione analitica della realtà
di CÉZANNE, dopo l'esplosione dello "scandalo" MALINOWSKI,
anche il cinema di CRONENBERG denuncia l'impossibilità di ricorrere alle
convenzionali figure retoriche per affrontare e descrivere la modernità.
E' per questo che mette in scena la densa virtualità del feticismo visuale
e le forme impazzite delle marronizzazioni culturali, la porosità di
un corpo in mutazione e la difformità straniante dell'ordinario, l'universo
del frammento e la schizoide convulsione dello sguardo. Videodrome, con l'impossibilità
della decifrazione epistemologica e il dominio assolutizzante dell'allucinazione,
Naked Lunch, con l'andamento puntiforme dell'esistere e l'abbattimento della
linearità del pensiero, Crash, con la disperata fissità del suo
intreccio e la lucentezza sensuale delle sue divoranti superfici, riflettono
ed amplificano quell'assillante ricerca di significati, quel diffuso disagio
generato dall'insufficienza degli attuali strumenti conoscitivi nei confronti
della natura complessa e decentrata dei nuovi scenari comunicativi.
La sovrapposizione, o giustapposizione, dei valori culturali è fenomeno
affatto nuovo, filiazione degenere o innovativa congiuntura della società
della comunicazione. Il potere dromologico e la pervasività dei mass
media, oltre a deformare e metamorfosare le categorie di spazio e tempo, centrifugano
e allo stesso tempo comprimono i valori relazionali ed i concetti di differenziazione,
frantumano le autorità unificanti e le griglie concettuali. Così
l'alterità si innesta nel quotidiano, l'esotismo permuta nel familiare,
il globale corteggia il locale.
Quella di CRONENBERG è una "estetica che valorizza il frammento,
le collezioni bizzarre, le giustapposizioni sorprendenti, che cerca di provocare
la manifestazione di realtà straordinarie tratte dai domini dell'erotico,
dell'esotico e dell'inconscio". Una definizione perfetta della sua poetica
d'autore, se non fosse che il virgolettato in questione si riferisce in realtà
ad una preziosa intuizione di JAMES CLIFFORD che tentava, con un pizzico di
provocazione, di accostare talune metodologie antropologiche con la prassi espressiva
del surrealismo parigino. L'intento è quello di considerare la cultura
e le sue norme come assetti artificiali, suscettibili di un'analisi distaccata
e di un confronto con altri orientamenti o altri sguardi possibili.
CRONENBERG come BRETON o ELUARD, come ARAGON o PÉRET, quindi; ad accomunarli
la passione collezionista per gli artefatti culturali, per le stramberie oggettistiche,
per il mescolamento straniante dei feticci, accumulati, raffazzonati, poi rivoltati
e cambiati di segno. La pistola innestabile organicamente o il televisore che
ansima in Videodrome, i pezzi del corpo in disfacimento di Seth Brundle in The
Fly, collezionati come fossero preziose esposizioni di un museo naturale, gli
attrezzi ginecologici "mutanti" dei fratelli Mantle in Dead Ringers,
le macchine da scrivere-insetto in Naked Lunch, le lamiere ed i rottami delle
automobili eroticamente accartocciati intorno alla carne umana in Crash, il
game-pod biologico che funziona come una playstation fremente ed ombelicale
in eXistenZ, sono strettamente imparentati con i reperti del Marché aux
puces parigino, luogo di culto e di cultura, prezioso archivio a cui attingevano
i surrealisti per le loro eteroclite miscellanee, oggetti d'uso comune trasformati
significativamente in forme bizzarre e spaventevoli, un po' come lo scolabottiglie
di MARCEL DUCHAMP.
Ma li accomuna ugualmente il ritratto di un mondo urbano (si veda il celebre
racconto Nadja di ANDRÉ BRETON del 1928 e la Toronto immaginata e metamorfosata
dal regista in film come Videodrome, Naked Lunch, Crash, eXistenZ) descritto
come fonte d'imprevisto, come significante che allude alla possibile esistenza,
"sotto la grigia vernice del reale, di un altro mondo più miracoloso
basato su principi di classificazione e di ordine radicalmente diversi".
Come LAUTRÉAMONT, anche CRONENBERG professa un'estetica della contaminazione
degli opposti, anela ad una bellezza generata dall'accostamento casuale degli
elementi, rincorre la grazia e l'armonia nel difforme, ribalta l'orrido e lo
strambo nel sensuale, fa della mutazione il suo paradigma rappresentativo.
* * *
Questa poetica del frammento si appoggia
su un preciso intendimento metodologico che richiama certe soluzione descrittive
utilizzate sia da WALTER BENJAMIN sia da GREGORY BATESON. CANEVACCI ricorda,
a proposito di BENJAMIN, che "questa sua sensibilità verso il "montaggio
di frammenti" in una forma-mosaico che non ha un finale preciso, si muove
sperimentando nuove forme retoriche della rappresentazione che, proprio su questa
base e negli stessi anni lo legano a BATESON e ai suoi nuovi linguaggi antropologici.
Lo stesso MARCUS cita BENJAMIN che, nel Dramma Barocco, afferma: "La rappresentazione
è la quintessenza del metodo. Il metodo è una via indiretta[…].
Costantemente il pensiero riprende da capo, circostanziatamente ritorna alla
cosa stessa", con "rinnovati avvii" e "ritmiche intermittenti",
come nei mosaici, in cui la frammentazione in capricciose particelle non lede
la maestà, la considerazione filosofica non soffre una perdita di empito[…].
Il valore dei frammenti di pensiero è tanto più decisivo quanto
meno essi saranno commisurati immediatamente con la concezione di fondo"
(1971: 8-9). L'atteggiamento micrologico trova qui la sua presentazione. E per
questo il "contenuto di verità" può essere colto solo
"penetrando con estrema precisione i particolari di un certo stato di cose"".
Caduta ogni gerarchizzazione si può lavorare sulle forme "aperte",
frastagliate, dissonanti; si fa scaturire dalla giustapposizione eteroclita
o dall'osservazione micologica un barbaglio di realtà, si gioca su una
dialettica tra il familiare e l'estraneo, dialettica che è costitutiva
della condizione moderna della cultura. Una cultura che si trasmette quasi esclusivamente
attraverso i poteri "forti" della comunicazione visuale, attraverso
le sue nuove tecnologie, attraverso i suoi dilatati linguaggi massmediali. Uno
scenario complesso che costringe gli studiosi della disciplina e gli intellettuali
in genere ad amalgamare i termini di una polarità (quella fra identità
ed estraneità), in un universo che miscela impercettibilmente affermazioni
localizzanti ed aperture globalizzanti.
"Tutto questo complica notevolmente le cose, in quanto è venuta
meno quell'istanza di estraneità che facilitava al ricercatore la rilevazione
delle diversità culturali: l'oggetto di studio si afferma prepotentemente
come coincidente con la propria identità culturale e, nello stesso tempo,
in continua mutazione. Per questa vischiosità dell'oggetto visuale, nasce
l'esigenza di precisare metodi e prospettive: è necessario, quindi, imparare
a osservare i singoli prodotti della comunicazione visuale come fossero esotici,
a utilizzare uno sguardo defamiliarizzante da parte dell'osservatore, a modificare
la propria sensibilità percettiva in un "farsi vedere"".
* * *
Ed è questo infatti l'approccio
metodologico utilizzato dalle correnti più innovative della ricerca antropologica
contemporanea. Un "rimpatrio" dell'antropologia nelle forme della
critica culturale è quantomeno necessario in uno scenario comunicativo
che produce sensi dissonanti e decentrati, al di fuori di ogni logica sociologizzante
e per niente assimilabili alle usurate strumentazioni estetico-culturali. La
ricerca cinematografica cronenberghiana è facilmente proponibile proprio
come efficace e competente modello di critica culturale; uno sguardo "etnografico"
che avvia, penetrando feticisticamente nella materia della comunicazione, nel
suo corpo avviluppante, una decodifica dissolutiva delle sue stranianti ed esotiche
fenomenologie.
Il materiale visuale diventa il nuovo campo d'indagine, il nuovo territorio
su cui concentrare l'osservazione partecipante. CRONENBERG assimila il tessuto
comunicativo all'elasticità dinamica del corpo biologico, proprio come
BATESON rende comprensibili le metodologie comunicative calandole in tutto il
loro spessore ecologico. I poteri della mente di Johnny Smith in The Dead Zone
(capace di amplificare la sua vista, solamente tramite il tatto, in una sorta
di onnipotenza mediale di natura crono-topologica) o quelli di Cameron Vale
in Scanners (che riesce a connettere la sua mente con il terminale di un computer
o di far entrare in tachicardia il suo interlocutore), concretizzano, seppure
declinati in senso plastico e spettacolare, le pregevoli intuizioni batesoniane
sulla trama che connette.
* * *
Le sue visioni, popolate da forme bizzarre, dilaniate da insostenibili mutazioni, esasperate da contorsioni linguistiche, sono allo stesso tempo specchio delle difformi categorie ermeneutiche dello scenario massmediale e sublimazioni eterotope delle nuove circonvoluzioni del pensiero. E quanto rifugga da una spettacolarità edonistica ed escapista, da un cinema asettico e disimpegnato, l'autore lo dimostra focalizzando la sua poetica e la sua osservazione sul mai abbastanza cartografato e parzialmente sconosciuto continente del corpo, universo penetrabile e cangiante, laboratorio teratologico, fremito della materia, involucro del pensiero, coacervo di biologico e culturale. Il corpo che, spazio feticistico per eccellenza, diviene il punto di partenza ed il termine ultimo per la pratica della scomposizione micrologica, per una nuova estetica del dettaglio e del frammento, per l'acquisizione di una inedita ermeneutica di carattere metonimico, per l'attuazione di una semiologia "fenomenologica".
| prefazione | capitolo1 | capitolo3 | torna a Pigrecoemme.com |