A.I. (Usa 2001) di Steven Spielberg con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Brendan Gleeson
Rischia di soffocare sotto
il pesante fardello delle incomprensioni e dei fraintendimenti uno dei
risultati artistici più alti dell'intera filmografia spielberghiana.
Accusato sia di tradire lo spirito caustico, il distacco beffardo, lo
sguardo analitico, l'ossessione demiurgica della messinscena kubrickiana
con la melassa consolatoria del suo neo-umanesimo, sia di aver raffreddato,
al limite dell'aridità emotiva, la sua comprovata capacità
manipolatoria, Spielberg ha in realtà diretto un film profondamente
provocatorio e destabilizzante, un'opera coraggiosa che ridefinisce, forse
in modo definitivo, il rapporto, finora rassicurante e giubilatorio, con
il suo pubblico.
Insomma nel portare sullo schermo un progetto a lungo accarezzato da Kubrick
(almeno dalla fine dei '70) Spielberg aveva tutto da perdere. Ma
va detto subito: nonostante l'indubitabile sottotesto kubrickiano,
A.I. è un film spielberghiano al cento per
cento. E, quindi, mai come per questo film la politique des auteurs
si rivela chiave di lettura indispensabile per il pieno riconoscimento
e la corretta analisi del risultato finale.
A.I. è nato, da parte di Spielberg, come pudico
omaggio a un genio del cinema, un omaggio rispettoso e commosso. Ma un
omaggio che Spielberg ha inteso non come pedissequa e imbarazzante
ripresa di finalità e topoi kubrickiani. Ha capito
cioè, molto prima di tanti giornalisti che si sono sentiti in dovere
di rimarcare la cosa con un senso di tronfio snobismo e provinciale folclore,
la non praticabilità del confronto espressivo col cineasta del
Bronx, la non belligeranza estetica con uno dei più autorevoli
e carismatici registi della storia del cinema.
La natura provocatoria del film si evince proprio dalla particolare operazione
che Spielberg ha fatto sul materiale kubrickiano: ha spiazzato
le attese di tutti portando all'esasperazione il suo insopprimibile côté
sentimentale ed emotivo, la sua sdolcinata naivité, lontana
mille miglia dal pessimismo materialistico di Kubrick, puntando
allo stesso tempo ad una ambizione espressiva e ad una risolutezza intellettuale
che non hanno eguali nella sua filmografia di hit miliardari. Dopo
la sfilza di successi artistici e commerciali degli ultimi tempi, ci pare
questo un atto di coraggio colpevolmente sottaciuto dalla stampa specialistica.
A.I. è, al di là della sua intrinseca valenza
polisemantica, uno straziante psicodramma, un poderoso vortice di emozioni,
una sfavillante cornucopia di idee, un prezioso regesto di momenti visionari,
ma soprattutto una commovente dichiarazione d'intenti e di poetica. Mai
prima d'ora Spielberg aveva osato portare allo scoperto, così
intensamente, così soffertamene, le sue più profonde convinzioni,
le sue più riposte speranze, le sue più inconfessabili paure.
Ogni fotogramma trasuda una densità drammatica, un'intensità
d'ispirazione, una tensione lirica che non si avvertiva da tempo nella
sua opera (almeno dalla prima, straordinaria, mezz'ora de L'impero
del sole e dalle scene della liquidazione del ghetto in Schindler's
List).
Ma l'ultima fatica di Spielberg è stata, e probabilmente
continuerà ad essere, vittima di un ironico contrappasso.



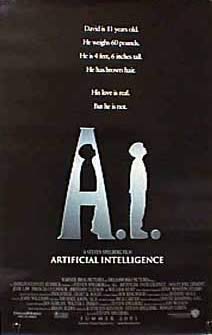

Destino ha voluto che l'opera
più attesa, più misteriosa, più apologetica del cineasta
più popolare e seguito della storia del cinema sia stata rifiutata
quasi in blocco dall'ostilità cinica e dal qualunquitisco disincanto
di quegli spettatori che avevano finora decretato la fortuna commerciale
del suo cinema e a cui anche quest'opera (per inconfessabile desiderio
di Kubrick e per espressa dichiarazione di Spielberg) era
destinata.
Senza la minima concessione a istanze e situazioni à la page,
senza pesanti riferimenti e ammiccamenti modaioli (com'era il caso per
intenderci di E.T., formidabile esercizio affabulatorio,
ma con profonde radici nell'immaginario e nella cultura di una America
paradigmaticamente middle-class), A.I. è senz'altro
la favola più universale del regista di Cincinnati, quella
più sincera e rigorosa. Forse anche la più personale, la
più meditata, certamente la più autorale.
Il che spiega forse le vere ragioni del suo insuccesso.
Non ci si riferisce soltanto alle istanze contenutistiche, ma soprattutto
alle soluzioni stilistiche adottate: il ricorso alle forme del melodramma
e del Bildungsroman a discapito della spettacolarizzazione fantascientifica,
il ritmo sottilmente meditativo, la totale mancanza di civetterie citazioniste,
il dosaggio felice dello schmaltz, l'assenza di stilemi e virtuosismi
compiaciuti (tranne qualche perdonabile occhieggio nella parte centrale),
il ricorso "poetico" ed espressionistico agli effetti speciali
(di una invisibilità davvero rivoluzionaria), il controllo emotivo
nelle scene madri (una scena straziante e potenzialmente patetica come
quella dell'abbandono di David nella foresta è risolta quasi
esclusivamente con l'utilizzo di campi medi).
Accusato da certa critica di essere un film diseguale, incompiuto, velleitario,
in balia della sua spiccata suddivisione in tre atti distinti e dei suoi
irrisolti scarti tonali, A.I. è un'opera che, tranne
per qualche lungaggine nella parte centrale (le scene nella Flesh Fair
risultano troppo cormaniane, un po' sdrucite e affrettate;
il pellegrinaggio di David e Gigolò Joe a Rouge
City non abbastanza scavato) vibra di una sostenutezza lirica e di
una misura espressiva che Spielberg sembrava aver definitivamente
accantonato con le sue ultime opere.
I primi cinquanta minuti sono dosati al millimetro, perfetti, il montaggio
di Michael Kahn è preciso come un bisturi e taglia le sequenze
del film in una serie di ellissi e condensazioni che producono una tensione
costante e a tratti insostenibile. Il viaggio a New York possiede
una stupefazione visionaria che non ha eguali nel cinema hollywoodiano,
e non solo. E, nell'epilogo, Spielberg osa l'inosabile. Si avventura
in territori in bilico fra l'esistenzialismo e il misticismo, spinge sul
pedale del sentimentalismo e della visionarietà, si mantiene programmaticamente
sospeso fra il sublime e il caramelloso, protrae in maniera agonica la
risoluzione della vicenda. Allora critiche in massa, infuriati anatemi,
risolini di disprezzo al finale, giudicato ridicolo quando non addirittura
disgustoso. In realtà ci pare non si possa dubitare non solo della
legittimità spettacolare e visiva, ma anche della logica narrativa
stringente, della omogeneità poetica delle ultime scene, fedeli
come sono agli assunti e alle premesse dell'opera (a differenza per esempio
di Schindler's List o di Salvate il soldato Ryan
che nel finale scivolavano in trappole parenetico-ricattatorie, sostanzialmente
estranee all'impianto sobrio e alla vivacità stilistica che caratterizzano
i loro presupposti filmici).
Ancora una volta, come anche in Incontri ravvicinati del terzo tipo
(opera quanto mai rappresentativa della sua poetica), Spielberg
testimonia, con maggior forza proprio nel finale del film, della sua fede
"religiosa" nel potere fondante dell'immaginario e nella forza
salvifica del sogno. Come la Devil's Tower era, oltre che luogo
di incontro fra umani ed extraterrestri, occasione di un film nel film,
toccante formalizzazione della sua professione di fabbricatore di sogni,
così anche le ultime scene di A.I. (forse gli unici
momenti del film che tradiscono una patente analogia strutturale con il
2001 kubrickiano) palesano un evidente contenuto
allegorico e metalinguistico, una suggestione metaforica che è
difficile sottovalutare.
Qui con una consapevolezza in più: che alla fiducia incondizionata
verso il vitalismo mitopoietico rappresentato dal cinema e alla speranza
messianica di una fratellanza panica si accompagna la presenza ineluttabile
della morte e della finitudine. Micidiale carezza, angelo nero di ogni
esistenza.
Così chi ha letto nel finale del film un inappropriato e scontato
happy-end, capace di cancellare del tutto, come con un colpo di
spugna, l'atmosfera melanconica e distopica del racconto, è sfuggito,
o ha rimosso, l'abisso psichico, il sortilegio amaro e disperato in cui
cade lo spettatore alla fine della visione.
(M.R.)